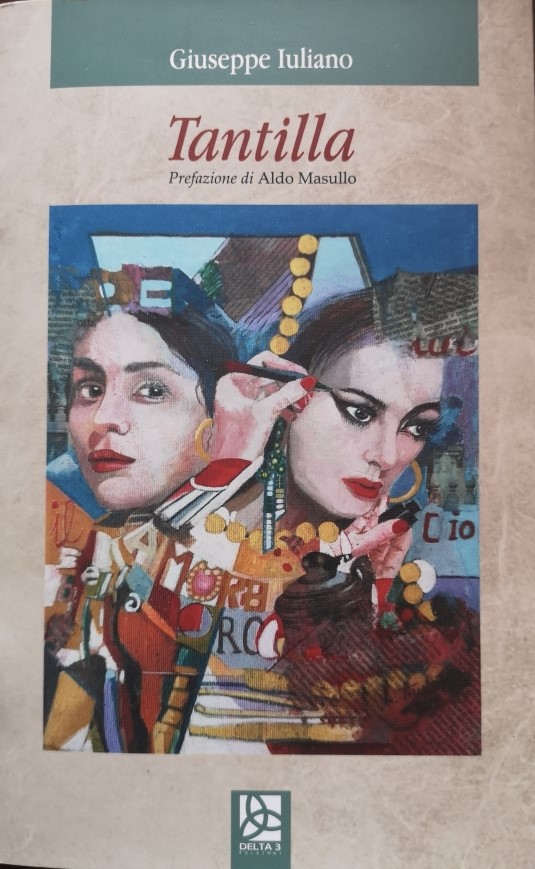Di Monia Gaita
“Tantilla”(cose da poco, di poco conto), è una silloge il cui titolo secerne e vidima un ossimorico guizzo con la materia fermentante, preziosa e ricca della parola. Il brulicare di una rivolta tenace, un fervore intellettuale saldamente insediati e impressi in un tematico affresco di impegno civile, in una sacra, dolente, iterata rappresentazione dell’anima. L’Irpinia assurge a luogo mitico e ancestrale dove i costituenti fisici vengono sottratti alle primigenie categorie di appartenenza, svestiti dei consueti abiti di erba, di fiori, di alberi, di pietra, per intarsiare un arco simbolico-allusivo che convoglia e agglutina, in propizia simultaneità, dimensione interiore e dimensione esteriore: «Qui trionfo di alberi e castagni/ si divide natura e povertà./ Qui si spremono ulivi/ polpa e vinaccioli torchio di precarietà/ nel giallo di terra tisica di abbandoni.»
Per il prefatore Aldo Masullo: «La sincope è la cifra stilistica dei Tantilla, e ne fa un atto politico. Essa costringe a non scambiare questi versi per un elegante idillio letterario, ancor meno per una colta illustrazione turistica, ma a sentire sulla pelle i laceranti graffi di una coscienza collettiva».
«Difficilmente è possibile trovare –sottolinea Franco Festa nel suo commento – in così poche pagine, un così potente concentrato di verità e di dolore,una impietosa radiografia poetica dello stato in cui ci siamo ridotti, in cui l’Irpinia è piombata».
Lo sguardo sulla fertile messe della natura si fa nostalgico nel registrare che quel dominio rischia di finire sgominato e morso dall’urto con la modernità:«Qui i temporali abbattono/ a saette piante di ogni età/ e nell’aria pulita o di piombo/ contiamo discariche di ogni rifiuto.»
Giuseppe Iuliano si muove lungo una direttrice di ricerca che reca con sé tutti gli indizi di scrostatura e sconnessione di una coscienza dimidiata. Una coscienza eterogenea e inespugnabile che perscruta il paesaggio nei suoi elementi, ne monitora commossa i riti antichi, reliquiario di relitti e di reperti accesi, provando con ardimento e furia a mantenerli vivi, a preservarli intatti nell’acredine e nella dignità della propria storia:«Campi “a spasso” non valgono disimpegno/ ma fuga abbandono fallimento./ Un tempo la terra-presepe combinava/ speranza capanna mangiatoia/ ricovero di famiglia uomini e bestie/ compagni di lavoro tra silenzi e bestemmie./ Terra altare di pietra, vetta croce di spighe/ consacri ostie di grano, calici bianchi di vino/ quaresime fiacche di veglia e preghiera/ che non saziano né angoscia né fame.» Il poeta dimora nel breve lasso di forbice divaricantesi tra accorata deprivazione dell’essere e rabbiosa sommossa di denuncia:«Ma qui s’affoga senz’acqua/ altra morte del Mediterraneo/ di un Sud carovana di nomadi/ che attraversa deserti di coscienze/ pozzi secchi a sorsi e brocche di sete.» Eppure la fastosa collana lessemica, in un’incalzante sequenza di perle, non ci riscatta dai decreti e dall’arbitrio del fato. A redimerci, inviolata e prolifica, è la grazia dei versi. E se, come l’autore dice:—Restano chiuse morte alla nostra storia le cataratte del cielo sovrane intatte infinite—questa poesia innesca un focolaio di spiragli e possibilità che attracca dalle risacche della resa ad un’insenatura di bellezza, di strenua lotta, di fermenti e determinazione a non permettere che la morte saccheggi tutti gli spazi. Una proposta alta, un antidoto alla dimenticanza, un robusto e accogliente ricovero contro lo sbriciolarsi delle radici. Una vertigine di levigata, stillante meraviglia che sfolgora in una scia di pensieri e interrogativi nel cui grembo, il caos e la ragione tappezzano una sola, irriducibile cupola di volontà. Un bacino testimoniale dove il coraggio e la belligeranza di resistere e dissentire vanno di pari passo, si stringono la mano, dando volume, ontologia e fiato all’etica del poeta che non si sente parte del sistema, che non capitola dinanzi alle ferite e ai mutili possessi dell’esistere.